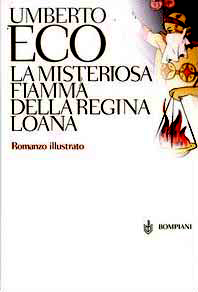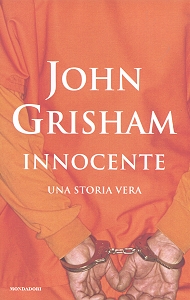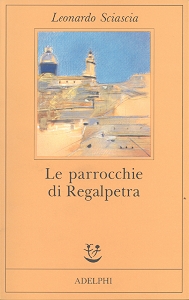Ma la Nazionale non è la Nazione
27 giugno 2010 alle 16:53 | Pubblicato su Cultura | Lascia un commento di ILVO DIAMANTI – Sociologo, politologo e saggista-
di ILVO DIAMANTI – Sociologo, politologo e saggista-
Nei giorni scorsi, abbiamo sentito e letto che “la Nazionale è lo specchio del Paese”. E, in fondo, della Nazione. Lo spettacolo della sciagurata esperienza degli azzurri ai mondiali in Sudafrica: una metafora della società e, soprattutto, della classe dirigente italiana. Vecchia, senza capacità di innovare, di inventare qualcosa. Ripiegata su se stessa. Povera di identità.
E per questo incapace di affrontare una competizione aperta e dura con altre nazioni. Più giovani e affamate di successi. Vero, per la Nazionale. Ma il discorso si ferma lì. L’identità nazionale non ha a che fare con quella della Nazionale. La Nazionale di calcio non è lo specchio del Paese o della Nazione. Anche se si è soliti dire che gli italiani esibiscono l’orgoglio nazionale solo quando gioca la Nazionale. Conviene, semmai, invertire il ragionamento. Gli italiani, la società italiana: “usano” il calcio come specchio. Quando e se conviene loro. Alla ricerca di buoni motivi per stare insieme e per sentirsi soddisfatti. Per riconoscersi. A maggior ragione quando altri motivi latitano. Quando l’economia va male e il lavoro manca. Quando si diffida delle istituzioni e degli altri. Allora si è più pronti a sfilare dietro a una bandiera che prometta e permetta di vincere. E, al contempo, di sentirsi comunità, in una società sempre più individualizzata.
I mondiali di calcio, peraltro, costituiscono un’occasione unica. Perché si tratta di competizioni “inter – nazionali”, dove le squadre “nazionali” si misurano “contro” le altre. Il che rende visibili gli elementi di eguaglianza e differenza impliciti nell’appartenenza territoriale. Sottolineati dalla bandiera, dall’inno, dalla maglia, dal tifo. Noi e gli altri. Noi contro gli altri. Amici e nemici (non avversari).
La svolta è avvenuta ai mondiali del 1970, nell’epica partita Italia – Germania, finita 4 a 3. Da allora è iniziata la ricerca di “momenti magici”. Come ai mondiali del 1982 e del 2006. Occasioni per riunirsi con amici e altre persone, a vedere la partita. A casa, nei bar, di fronte a megaschermi. Per poi sciamare tutti quanti in strada e in piazza, in caso di vittoria. Offrendo (e assistendo a) spettacoli di entusiasmo collettivo. In cui ci si sente, all’improvviso, per una volta, italiani. Perché è bello vincere. Godere “insieme”. Tanto più se negli altri momenti ci sentiamo soli. Se il successo arriva inatteso. Anzitutto da noi.
Naturalmente, il calcio è lo spettacolo che, più di altri, alimenta – e si alimenta – di identità e di appartenenza. Locale, urbana, regionale e non solo. In Italia il 50% delle persone tifa per una squadra. E, al tempo stesso, “contro” un’altra squadra (Sondaggio Demo – Limes, luglio 2008). Tra i più giovani la bandiera della squadra di calcio conta più di ogni altra. Politica, ma anche religiosa. È una “fede” più che una passione. Per questo la politica se ne è impadronita. A costo di ripetersi, come dimenticare l’esempio di Silvio Berlusconi, inventore della Nuova Politica e della Nuova Repubblica?
Nel 1994, proprietario e presidente del Milan, oltre che di Fininvest. Fonda un partito che si chiama “Forza Italia”, organizzato attraverso i club. Definisce i suoi elettori: “azzurri”. Un progetto post – ideologico, che definisce il Paese come una massa di tifosi, coinvolti in un campionato permanente, che si svolge sotto gli occhi di tutti, sui media. In chiaro o in pay – per – view.
Logico che il calcio, in una politica mediatizzata, sia divenuto il terreno dove si elaborano, creano, promuovono, scontrano le identità. Anche se la Nazionale non è la Nazione, viene usata per promuoverne oppure delegittimarne il significato. Secondo la convenienza. Come ha fatto, apertamente, la Lega, in questa occasione. Identificando – lei sì – la Nazionale con la Nazione. Per metterne in dubbio il fondamento. Così, Radio Padania ha “tifato contro”. In seguito, Bossi si è detto certo che l’Italia (Nazione e nazionale) avrebbe “comprato” gli slovacchi, per vincere la partita e qualificarsi. (Nel calcio, si sa, queste cose succedono). Smentito dal risultato, ha usato l’eliminazione in senso “nazionalista”. Recriminando sull’eccessiva presenza di stranieri. Nel campionato, ma, ovviamente, anche nella società italiana. (Varrebbe la pena di prendere sul serio questa critica, per allargare la rosa della nostra Nazionale, “etnicamente pura”. Come avviene quasi ovunque.)
Negli ultimi anni, peraltro, anche Berlusconi sembra aver preso le distanze dal calcio. Ha smesso di investire nel Milan. Perché il Premier non può spendere cifre immense per i giocatori del suo club e chiedere, al tempo stesso, sacrifici ai cittadini. Poi, ha sciolto “Forza Italia” e gli “azzurri” (nel Popolo della Libertà). Forse, (anche) per ridurre i motivi di tensione con il fedele alleato “padano”. Forse perché il calcio è diventato, nel frattempo, un’arena di guerra per bande. Localiste ed estremiste. Una piazza mediatica ingovernabile. Dove è impossibile coltivare un sogno “comune”. Celebrare una storia “italiana”.
La Nazionale, dunque, non è lo specchio della Nazione e neppure del Paese. Lo può diventare solo quando ai cittadini e alla classe dirigente “conviene” specchiarsi in essa. Cioè: se vince e (possibilmente) convince. Altrimenti, viene negata e rinnegata. Oppure ignorata. Come ieri, al ritorno degli azzurri, in aeroporto. Pochi tifosi, qualche insulto e molta indifferenza.
Noi, post-italiani (copyright di Berselli), per dirci e sentirci di nuovo italiani – e orgogliosi di essere tali – attenderemo un’occasione migliore.
Fonte: www.repubblica.it
Cogito ergo sum
27 gennaio 2010 alle 08:33 | Pubblicato su Attualità, Cultura | 3 commenti Avevo abbandonato questo blog e non so neanch’io il perchè. Le oltre 50 mila pagine visitate ( molte durante la mia “assenza”) mi hanno fatto riflettere a lungo. Da oggi in avanti cercherò di aggiornarlo “Pollakis”. Questo è il mio diario, la mia valvola di sfogo; lo strumento per sentimi vivo dentro. “Cogito ergo sum” diceva Cartesio: “Penso dunque sono”. E i miei pensieri, così come il mio grande padre spirituale Josè Saramago asserisce “sulle parole”, sono l’unica cosa immortale. Su questo diario di bordo di un navigatore pensante che “la dritta via avea smarrita, renderò, a modo mio, l’ immortalità ai miei pensieri; per cercare di dare un senso alla vita. Alla mia esistenza che in questo particolare momento, ha un retrogusto dal sapore agrodolce.
Avevo abbandonato questo blog e non so neanch’io il perchè. Le oltre 50 mila pagine visitate ( molte durante la mia “assenza”) mi hanno fatto riflettere a lungo. Da oggi in avanti cercherò di aggiornarlo “Pollakis”. Questo è il mio diario, la mia valvola di sfogo; lo strumento per sentimi vivo dentro. “Cogito ergo sum” diceva Cartesio: “Penso dunque sono”. E i miei pensieri, così come il mio grande padre spirituale Josè Saramago asserisce “sulle parole”, sono l’unica cosa immortale. Su questo diario di bordo di un navigatore pensante che “la dritta via avea smarrita, renderò, a modo mio, l’ immortalità ai miei pensieri; per cercare di dare un senso alla vita. Alla mia esistenza che in questo particolare momento, ha un retrogusto dal sapore agrodolce.
LA MERAVIGLOSA ARTE DELLA SCRITTURA
9 dicembre 2008 alle 18:54 | Pubblicato su Cultura | Lascia un commento
di Maria Vittoria Montedoro ( 9 anni e mezzo)
Tra gli antichi, nella Mesopotamia i Sumeri furono il primo popolo che imparò l ‘ arte della scrittura; con caratteri cuneiforme , cioè a forma di chiodi . Oggi la scrittura è cambiata e per scrivere usiamo le lettere e le punteggiature, fondamentali per scrivere. Ci sono tre caratteri che si possono usare: il corsivo, lo stampato e lo stampato minuscolo. Di solito si impara a scrivere, ma anche a leggere a scuola e si possono scrivere testi, racconti,lettere, piccoli biglietti, numeri ecc. SI può scrivere anche con il computer via e- mail , fax, telegrammi e altro, ed è proprio questa la nostra rovina . Oggi scrivono tutti con il computer dimenticandosi la vecchia maniera : “ carta e penna”, questa è una cosa molto brutta perché si vede originalità nelle persone che preferiscono un foglio e una penna, ad un computer. Dico, come si fa a spedire un messaggio con una e-mail?, sarebbe come se uno tentasse di scrivere e dietro a lui una gomma che cancella. Spero che come me ci sia qualcun’altro che usa: “la maestosa arte della scrittura”, e che a volte fa a meno dell’elettronica. Perché oggi possiamo dare tutto per scontato e ci chiediamo come facevano gli antichi senza usare quella “scatola che scrive” che si chiama computer. Io direi che senza la scrittura bisognerebbe sempre usare le parola ed in certe circostanze è meglio scrivere. Tuttavia c’è chi farebbe a meno delle lettere, ma no! Non dobbiamo fare così perché la scrittura è un arte come la pittura, pennello e tempere si sposano e stanno bene insieme, anche foglio e penna si sposano e danno vita a sentimenti, amore, fantasia ed immaginazione, qualcuno non ha nessuno di questi sentimenti o doti e tende a restare alla larga da chi invece le ha. Sono ancora molto piccola, forse lo sono troppo per scrivere queste cose ma spero di diventare una scrittrice perché è un sogno che vale la pena inseguire, scrivere e regalare emozioni, ma se questo sogno sarà solo chiuso in un cassetto mi limiterò a scrivere per chi mi è vicino e soprattutto per chi mi vuole bene.
“La misteriosa fiamma della regina Loana” di Umberto Eco
24 agosto 2007 alle 16:41 | Pubblicato su Cultura | 2 commentidi: William Ghilardi
Rieccomi di nuovo a parlare del piú grande scrittore (anche se scrivere romanzi per lui é solo un hobby) vivente: Umberto Eco. “La misteriosa fiamma della regina Loana” é uno di quei romanzi che lo leggi e ti arricchisci. Uno spaccato di storia d´Italia. Ma una storia raccontata, come ce la si aspetterebbe da un nonno che l´ha veramente vissuta, ma al tempo stesso riscoperta come ci aspetterebbe da uno che l´ha dimenticata come il protagonista del romanzo. Non le vicende politche, gli intrighi, le cronache. Nossignore, qui raccontiamo la storia dell´uomo della strada, quella che non trovi su nessun libro di storia. Come si viveva, cosa si faceva allora, quali ansie e quali preoccupazioni aveva l´uomo del tempo, cosa leggeva, cosa ascoltava. Insomma l´uomo concreto quasi tangibile e non l´uomo astratto al quale ci abituano i libri di storia. E la raccontiamo con gli occhi di un uomo che ha perso la memoria. Un uomo che non sa piú chi é, come si chiama, chi é la sua famiglia. La raccontiamo con gli occhi di un uomo che cerca di ricostruire il suo passato, la sua storia come un archeologo cerca di ricostruire la storia di un popolo vissuto milleni fa, attraverso i documenti sopravvissuti, foto, ritagli di giornale, dischi, ambienti, personaggi. E li la ricerca della propria identitá si confonde con la storia d´Italia degli ultimi decenni. Non ho detto come si chiama il protagonista di questo romanzo, perché il protagonista del romanzo “la misteriosa fiamma della regina Loana” é chi lo legge.
Riflessione sulla morte
14 agosto 2007 alle 03:21 | Pubblicato su Cultura | 3 commentiNon passa giorno che non legga sui quotidiani locali dell’ennesimo incidente mortale sulle strade del Salento. Una vera e propria “mattanza” che non si riesce a fermare e che si protrae da mesi e mesi. Spesso si tratta di giovani vite spezzate, di ragazzi che incontrano prematuramente la “signora” senza volto, avviluppata nel suo sventolante mantello nero che impugna con una mano una lunga falce. Ho cercato di immaginare questo insolito e tragico appuntamento con la morte: Lei è lì ad aspettare sul ciglio della strada per quell’incontro indesiderato, non voluto ma gia stabilito per tutti al momento del concepimento in grembo materno; una spada di Damocle che portiamo sulla testa fin dalla nascita. Quel percorso di vita e di morte scritto con inchiostro indelebile su quella lucida lama di questa dama nerovestita che è lì ad attenderci, impassibile, senza alcun sentimento di rimorso, crudele, spietata, priva di vitalità della quale è assetata e sua unica e sola fonte di nutrimento. Pronta a catturare l’ennesima preda, mai sazia di quel bottino che ogni giorno si fa sempre più cospicuo. La morte si sa, è cieca, colpisce senza alcuna logica, è irrazionale nella sua lucidità; ti prende quando vuole e non da mai, non le dobbiamo nulla fino a quando non è lei a pretendere, senza deroghe, senza regole, senza alcuna possibilità di rimandare quell’incontro, nessuna possibilità di rinunciarvi. Sic et simpliciter. La morte è onnipotente, proprio come il nostro buon Dio: stessa grandezza, stessa onnipresenza, stessi poteri, stessa fonte di nutrimento. La morte e la vita: senza l’una non ci sarebbe l’altra, entrambe protagoniste della nostra esistenza, lunga o breve che sia. « …sono la morte e sono qui per te – dice al giovane – », «…prendi qualcun altro, io ho ancora voglia di vivere, sono giovane, vorrei sposarmi, fare dei figli, amare tutti i miei cari – disse il ragazzo…», ….« ….è stato gia scritto ….– sentenziò la morte…..».
“Baudolino” di Umberto Eco
11 agosto 2007 alle 07:37 | Pubblicato su Cultura | 3 commentiMolti non saranno d’accordo con me ma credo che “Baudolino” sia il romanzo più lucido di Umberto Eco, forse il più bello e certamente il più felice dopo “Il nome della rosa”, scritto dal professore di semiotica nel lontano 1980. In questo romanzo storia e fantasia si intrecciano, così come i suoi personaggi. Dal “fantastico” Baudolino, protagonista principale, figlio di contadini che riuscirà con la sua indole fantasiosa e millantatrice ad entrare nelle grazie del temuto imperatore tedesco Federico Barbarossa, a Niceta Coniate, personaggio realmente vissuto, storico bizantino nonché cancelliere del basileo di Bisanzio. Sarà proprio Baudolino a trovarsi nel bel mezzo dell’assedio di Costantinopoli e a dover raccontare a Niceta la sua storia ripercorsa in 60 anni. Capitolo dopo capitolo racconterà, tra storico e fantastico, di amori impossibili, di feroci battaglie, di grandi storie di odio ed amicizie, di intrighi ed aneddoti. A mio avviso molto dotta ed interessante è la narrazione che riguarda la nascita e l’espansione di alcune grandi città del nord sotto il regno di Federico Barbarossa: Tra queste la storia di Alessandria, città natale di Umberto Eco.
“Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini
7 agosto 2007 alle 15:22 | Pubblicato su Cultura | Lascia un commento“Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini è un libro che ho letto un paio di mesi fa. A dire il vero lo avevo comprato per regalarlo a mia moglie, rimasta entusiasta in occasione di un articolo apparso su un settimanale che ne recensiva il racconto. In genere, tra le prime cose che si leggono, all’inizio di un romanzo, ci sono le biografie degli autori, la sintesi del racconto ed in alcuni casi la critica in pillole di autorevoli riviste specializzate. Mi ha colpito molto il giudizio dato dal sito http://www.amazon.com/ che dice testualmente: “ Questo libro ha un solo difetto: lo si divora troppo in fretta”. Aveva ragione. Il romanzo è talmente avvincente e straordinario che l’ho letto in un paio di giorni o poco più. E’ la storia di un amicizia profonda tra Amir ed Hassan e lo scenario è quello di un Afganistan ai tempi dell’occupazione sovietica, successivamente “liberato” per modo di dire, dai Talebani. Se mi è consentito un personale giudizio, direi che è un romanzo propedeutico, da consigliare a tutti quelli che non riescono a leggere un libro, magari spaventati dalle 390 pagine che compongono questo romanzo. La lettura è scorrevole e “leggera”, un lessico semplice e chiaro, privo di paroloni. Insomma ci sono tutti i presupposti per leggerlo tutto. Come al solito vi anticipo un riassunto del racconto: __
C’è stato un tempo in cui Kabul era una città in cui volavano gli aquiloni e in cui i bambini davano loro la caccia. Amir e Hassan hanno trascorso lì la loro infanzia felice e formavano una coppia eccezionale nei tornei cittadini di combattimenti tra aquiloni. Niente al mondo però può cambiare certi dati di fatto: l’uno pashtun, l’altro hazara; l’uno sunnita, l’altro sciita; l’uno padrone, l’altro servo. Amir, il ricco, era il pilota; Hassan, il servo, era il suo secondo. Poi però gli aquiloni non volarono più. E’ una storia di padri e figli, di amicizia e tradimento, di rimorso e redenzione, di fughe e ritorni sullo sfondo di un Afghanistan schiacciato dalla morsa sovietica prima e dai talebani poi. Amir, figlio di un ricco uomo d’affari, viveva con il padre Baba in quella che era considerata da tutti la più bella casa di Wazir Akbar Khan, un nuovo quartiere nella zona nord di Kabul. Anche Hassan viveva con il padre Ali, in una capanna di argilla, all’ombra del nespolo situato all’estremità meridionale del giardino della casa di Baba e Amir. Ma un giorno, sotto gli occhi dell’amico, qualcosa di terribile accadde ad Hassan. Amir commise una colpa terribile e l’armonia tra i due si infranse. “Sono diventato la persona che sono oggi all’età di dodici anni, in una gelida giornata invernale del 1975. Ricordo il momento preciso: ero accovacciato dietro un muro di argilla mezzo diroccato e sbirciavo di nascosto nel vicolo lungo il torrente ghiacciato. E’ stato tanto tempo fa. Ma non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente. Sono ventisei anni che sbircio di nascosto in quel vicolo deserto. Oggi me ne rendo conto.” Queste le parole di Amir adulto che vive da ormai vent’anni in America, dove è fuggito con il padre. E, quando una telefonata inaspettata lo raggiunge a San Francisco, comprende che deve partire e tornare a casa. Un viaggio di ritorno, un viaggio dentro di sé, un viaggio di espiazione, un viaggio di riscatto. Ricordi assordanti e prorompenti, sensazioni sopite ma mai dimenticate. Ad attenderlo non ci sono però solo i rimorsi e i fantasmi della sua coscienza; quella che una volta era casa e patria è ora una landa desolata, terra di relitti umani e di donne invisibili la cui bellezza non esiste più. Qui avere un padre o un fratello, dopo gli indiscriminati stermini dei talebani, è una vera rarità; qui incrociare il loro sguardo, il più delle volte, significa tortura e morte; qui regnano sgomento e terrore. Nonostante il finale “americano” e cinematografico (la Dreamworks casa di produzione di Steven Spielberg ne ha acquistato i diritti per trarne un film) è una storia toccante e coinvolgente che vale la pena di leggere e su cui riflettere.
«Caccia agli scienziati nazisti»
2 agosto 2007 alle 21:26 | Pubblicato su Cultura | 1 commentoVivevo a Novara e quel giorno (probabilmente una domenica) decisi di andare a trovare amici a Milano. Mi fermai in edicola con l´idea di comprare un giornale da leggere in treno (la linea Torino-Milano é la piú disgraziata d´Italia con ritardi che a volte raggiungono l´ora, a volte un giornale aiuta a sopportare i disagi…), ma mi resi conto che con il costo di un giornale potevo comprare uno di quei libri che nessuno vuole da anni. Fu cosí che mi capitó tra le mani per la miseria di 1500 lire un libro che mi fece riflettere come pochi altri nella mia vita. “Caccia agli scienziati nazisti” di Michel Bar-Zohar. In questo libro si parla di un curioso bottino di guerra che gli alleati hanno razziato alla sconfitta Germania nazista. Un bottino fatto non di beni ma di cervelli. Il titolo parla di scienziati, in realtá il grosso dei protagonisti sono ingegneri, gli unici veri scienziati di cui si parla sono il “barone rosso” (Manfred von Ardenne ) e Werner Karl Heisenberg ovvero l´uomo dell´ “atomica nazista”. Per gli interessati esiste ancora nella leggendaria cittá di Haigerloch il laboratorio dove Heisenberg e i suoi collaboratori hanno lavorato per dare a Hitler la bomba atomica (fortunatamente senza successo). http://www.haigerloch.de/stadt/keller_englisch/EKELLER.HTM
Torniamo al libro ovvero alla storia di questi ingegneri (il piú famoso dei quali fu Werner von Braun) che divennero selvaggina di lusso per i cacciatori americani e sovietici che volevano e bisognavano di cervelli per costruire gli armamenti che tolsero il respiro a tutto il pianeta durante gli anni della guerra fredda. Pochi sanno, ad esempio, che il contributo di questi uomini permise ai russi di mandare lo Sputnik in orbita, pochi sanno che al progetto Manhattan lavorarono fisici che erano fuggiti alla ferocia nazista. Pochi sanno che dopo la seconda guerra mondiale i tecnici e ingegneri che non trovarono lavoro presso gli americani o presso i sovietici si misero a lavorare per il presidente egiziano Nasser e al suo sogno di cancellare lo stato israeliano. Ma non sono tanto le vicende storiche che mi hanno colpito, quanto piú di tutto le vicende umane di questi uomini. E soprattutto mi ha colpito e scosso il fatto di come questi uomini dalla straordinaria intelligenza venivano impiegati a costruire armi per distruggere. Asimov scrisse che la curiositá ha trasformato l´animale in Uomo e lo scrisse con parole molto forti, che ricordano la Bibbia:”In principio era la curiositá”. Questo bisogno di scoprire e svelare i segreti della natura é stato usato per distruggerla. Come questo sia accaduto, lo racconta Michel Bar-Zohar in questo libro.
‘da sinistra a destra: W.K. Heisemberg e M.Von Ardenne
John Grisham: «INNOCENTE» Una storia vera
31 luglio 2007 alle 17:31 | Pubblicato su Cultura | 2 commentiPer una buona lettura sotto l’ombrellone propongo ai visitatori del mio blog un romanzo uscito già da alcuni mesi: «INNOCENTE» scritto da John Grisham, il re indiscusso dei “Legal Thriller”. Questa volta, a differenza degli altri romanzi di Grisham (tranne l’autobiografico “La casa dipinta”), siamo di fronte ad una storia vera che non è frutto della fantasia dell’autore. Un uomo è ingiustamente condannato per omicidio e rinchiuso in uno dei tanti bracci della morte sparsi per i penitenziari degli Stati Uniti d’America. E’ la storia di Ron Williamson, ex promessa del baseball che, quando sta per sfondare nel mondo dei professionisti è fermato da un grave infortunio al braccio che ne comprometterà irrimediabilmente la carriera. Dal quel momento inizia la spirale discendente, prima con la depressione, accompagnata da un uso massiccio d’Alcool e marijuana, poi lo stato d’infermità mentale. Entra ed esce dalla galera. Il più delle volte per guida in stato d’ubriachezza. E’ accusato un paio di volte di stupro, ma grazie all’aiuto di un avvocato, amico di una delle sorelle, viene scagionato. Fino a quando non è accusato ingiustamente dell’omicidio di una giovane ragazza del suo paese e tenuto in galera per ben 19 anni prima di ottenere giustizia. Lo sto leggendo in questo momento e devo dire che è veramente bello e appassionante. Qui di seguito una sintesi della storia.
<
La storia:
L’8 dicembre 1982, nella cittadina di Ada, in Oklahoma, la giovane Debbie Carter viene ritrovata da un’amica sul pavimento della propria casa. È nuda, coperta di sangue, e qualcuno ha scritto parole incomprensibili sul suo corpo. Ada è una tranquilla località del Midwest, dove tutti si conoscono e si ritrovano in chiesa. Nessuno avrebbe mai creduto possibile un omicidio tanto sanguinoso, e la stessa polizia è impreparata all’evento. Per quasi cinque anni il caso rimane irrisolto, fino a quando gli inquirenti non decidono di incriminare Ron Williamson, già noto alle forze dell’ordine per i suoi comportamenti bizzarri, al limite della follia. In “Innocente” John Grisham ricostruisce con la precisione del legale e l’empatia del grande romanziere la vicenda personale e giudiziaria di Williamson. Promettente giocatore di baseball, Ron lascia Ada nel 1971 per trasferirsi a Oakland, in California, come prima scelta della squadra professionistica locale. Sei anni dopo, i suoi sogni si infrangono per colpa di un infortunio al braccio. Rifugiatosi nell’alcol e nelle droghe, tornerà da sconfitto in Oklahoma, incapace di mantenere un lavoro o un qualsiasi rapporto stabile e mostrando progressivi segni di squilibrio. Quando la polizia si convince che è lui l’assassino di Debbie Carter, Williamson non ha modo di difendersi. Non ha denaro per pagarsi un avvocato decente, i suoi concittadini lo guardano con sospetto e la malattia mentale lo rende inabile ad affrontare un processo. Nonostante gridi la propria innocenza,Williamson verrà travolto da una spirale giudiziaria che lo porterà nel braccio della morte, e a un passo dall’esecuzione. Il caso di Ron Williamson ha ossessionato John Grisham per anni, da quando il maestro del legal thriller ha letto incidentalmente la sua vicenda su un giornale locale, decidendo di raccontare per la prima volta un fatto realmente accaduto. Il risultato è una storia umana avvincente e scioccante, pervasa di una forte tensione morale, che arriva a mettere in discussione l’intero sistema legale americano.
Lettera aperta di Salvatore Borsellino
24 luglio 2007 alle 16:46 | Pubblicato su Cultura | Lascia un commentoRiviste e giornali hanno dato pochissimo risalto a questa lettera. Molto probabilmente all’estero susciterà più interesse. A volte tocca a noi blogger informare i lettori e sostituirci a chi scrive per mestiere. Questa lettera/denuncia di Salvatore Borsellino, fratello del compianto Paolo, è stata scritta e divulgata sul web dal 15 luglio u.s.
19 Luglio 1992 : Una strage di stato
Per anni, dopo l’estate del 1992 sono stato in tante scuole d’Italia a parlare del sogno di Paolo e Giovanni, a parlare di speranza, di volontà di lottare, di quell’alba che vedevo vicina grazie alla rinascita della coscienza civile dopo il loro sacrificio, dopo la lunga notte di stragi senza colpevoli e della interminabile serie di assassini di magistrati, poliziotti e giornalisti indegna di un paese cosiddetto civile. Poi quell’alba si è rivelata solo un miraggio, la coscienza civile che purtroppo in Italia deve sempre essere svegliata da tragedie come quella di Capaci o di Via D’Amelio, si è di nuovo assopita sotto il peso dell’ indifferenza e quella che sembrava essere la volontà di riscatto dello Stato nella lotta alla mafia si è di nuovo spenta, sepolta dalla volontà di normalizzazione e compromesso e contro i giudici, almeno contro quelli onesti e ancora vivi, è iniziata un altro tipo di lotta, non più con il tritolo ma con armi più subdole, come la delegittimazione della stessa funzione del magistrato, e di quelli morti si è cercato da ogni parte di appropriarsene mistificandone il messaggio. Per anni allora ho sentito crescere in me, giorno per giorno, sentimenti di disillusione, di rabbia e a poco a poco la speranza veniva sostituita dalla sfiducia nello Stato, nelle Istituzioni che non avevano saputo raccogliere il frutto del sacrificio di quegli uomini, e allora ho smesso di parlare ai giovani convinto che non era mio diritto comunicare loro questi sentimenti, soprattutto che non era mio diritto di farlo come fratello di Paolo che, sino all’ultimo momento della sua vita, aveva sempre tenuto accesa dentro di sé, e in quelli che gli stavano vicino, la speranza, anzi la certezza, di un domani diverso per la sua Sicilia e per il suo Paese. Per anni allora non sono neanche più tornato in Sicilia, rifiutandomi di vedere, almeno con gli occhi, l’abisso in cui questa terra era ancora sprofondata, di vedere, almeno con gli occhi, come tutto quello contro cui Paolo aveva lottato, la corruzione, il clientelismo, la contiguità fossero di nuovo imperanti, come nella politica, nel governo della cosa pubblica, fossero riemersi tutti i vecchi personaggi più ambigui, spesso dallo stesso Paolo inquisiti quando ancora in vita, e nuovi personaggi ancora peggiori dato che ormai oggi essere inquisiti sembra conferire un’aureola di persecuzione e quasi costituire un titolo di merito. Da questa mia apatia, da questo rinchiudermi in una torre d’avorio limitandomi a giudicare ma senza più volere agire, sono stato di recente scosso da un incontro illuminante con Gioacchino Basile, un uomo che ha pagato sempre di persona le sue scelte, che, all’interno dei Cantieri Navali di Palermo e della Fincantrieri, ha sempre condotto, praticamente da solo e avendo contro lo stesso sindacato, quella lotta contro la mafia che sarebbe stata compito degli organismi dello Stato, Stato che invece, secondo le sue circostanziate denunce, intesseva accordi con la mafia trasformando le Partecipazioni Statali in un organismo di partecipazione al finanziamento e al potere della mafia in Sicilia. I fatti riferiti in queste denunce, di cui Paolo Borsellino si era occupato nei giorni immediatamente precedenti il suo assassinio, sono state oggetto di una “Relazione sull’infiltrazione mafiosa nei Cantieri Navali di Palermo” da parte della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia (relatore on. Mantovano) ma come purtroppo troppo spesso succede in Italia con gli atti delle commissioni parlamentari, non hanno poi avuto sviluppi sul piano parlamentare mentre su quello giudiziario, come sempre succede quando si passa dalle indagini sulla mafia a quello sui livelli “superiori”, hanno subito la consueta sorte dell’archiviazione. Gioacchino Basile è convinto che l’interesse personale che Paolo gli aveva assicurato nell’approfondimento di questo filone di indagine e l’averne riferito in uno dei suoi incontri a Roma nei giorni immediatamente precedenti la sua morte, sia il motivo principale della “necessità” di eliminarlo con una rapidità definita “anomala” dalla stessa Procura di Caltanissetta e che la sparizione di questo dossier dalla borsa di Paolo sia stata contestuale alla sottrazione dell’agenda rossa. Per parte mia io credo che questo possa essere stato soltanto uno dei motivi, all’interno del più ampio filone “mafia-appalti” che lo stesso Paolo aveva fatto intuire fosse il motivo principale dell’eliminazione di Giovanni Falcone insieme alla sua ormai certa nomina a Procuratore Nazionale Antimafia. Il motivo principale credo invece sia stato quell’accordo di non belligeranza tra lo stato e il potere mafioso che deve essergli stato prospettato nello studio di un ministro negli incontri di Paolo a Roma nei giorni immediatamente precedenti la strage, accordo al quale Paolo deve di sicuro essersi sdegnosamente opposto. Su questi incontri, che Paolo deve sicuramente aver annotato nella sua agenda scomparsa, pesa un silenzio inquietante e l’epidemia di amnesie che ha colpito dopo la morte di Paolo tutti i presunti partecipanti lo ha fatto diventare l’ultimo, inquietante, segreto di Stato, come inquietanti sono i segreti di Stato e gli “omissis” che riempiono le inchieste su tutte le altre stragi di Stato in Italia. Ma il vero segreto di Stato, anche se segreto credo non sia più per nessuno, è lo scellerato accordo di mutuo soccorso stabilito negli anni tra lo Stato e la mafia. A partire da quando i voti assicurati dalla mafia in Sicilia consentivano alla Democrazia Cristiana di governare nel resto dell’Italia anche se questo aveva come conseguenza l’abbandono della Sicilia, così come di tutto il Sud al potere mafioso, la rinuncia al controllo del territorio, l’accettazione della coesistenza, insieme alle tasse dello Stato, delle tasse imposte dalla mafia, il pizzo e il taglieggiamento. E, conseguenza ancora più grave, la rinunzia, da parte dei giovani del sud, alla speranza di un lavoro se non ottenuto, da pochi, a prezzo di favori e clientelismo e negato, a molti, per il mancato sviluppo dell’ industrializzazione rispetto al resto del paese. A seguire con il “papello” contrattato da Riina con lo Stato con la minaccia di portare la guerra anche nel resto del paese (vedi via dei Georgofili e via Palestro), contrattazione che è stata a mio avviso la causa principale della necessità di eliminare Paolo Borsellino, e di eliminarlo in fretta. A seguire, infine, con l’individuazione di nuovi referenti politici dopo che le vicende di tangentopoli aveva fatto piazza pulita di buona parte della precedente classe politica e dei referenti “storici”. Accordi questi che costituiscono la causa del degrado civile di oggi dove si consente che indagati per associazione mafiosa governino la Sicilia e dove, a livello nazionale, cresce, almeno nei sondaggi, il consenso popolare verso chi ha probabilmente adoperato capitali di provenienza mafiosa per creare il proprio impero industriale con annesso partito politico. Come possono allora chiamarsi “deviati” e non consoni all’essenza stesso di questo Stato quei “Servizi” che, per “silenzio-assenso” del capo del Governo o su sua esplicita richiesta, hanno spiato magistrati ritenuti e definiti “nemici” nei relativi dossier e addirittura convinto altri magistati a spiare quei loro colleghi che, sempre negli stessi dossier, venivano definiti come “nemici”, “comunisti” e “braccio armato” della magistratura, con un linguaggio che non è difficile ritrovare negli articoli di certi giornali e nelle dichiarazioni di certi poltici. Giaocchino Basile mi dice che sarebbe mio diritto “pretendere” dallo stato di conoscere la verità sull’assassinio di Paolo, ma da “questo” Stato, dal quale ho respinto “l’indennizzo” che pretendeva di offrirmi quale fratello di Paolo, indennizzo che andrebbe semmai offerto a tutti i giovani siciliani e italiani per quello che gli è stato tolto, sono sicuro che non otterrò altro che silenzi. Gli stessi silenzi, lo stesso “muro di gomma”, che hanno dovuto subire i figli del Generale Dalla Chiesa, i parenti dei morti in quella interminabile serie di stragi, la strage di Portella della Ginestra, la strage di Piazza Fontana, la strage di Piazza della Loggia, la strage del Treno Italicus, la strage di Ustica, la strage di Natale del rapido 904, la strage di Pizzolungo, le stragi di Via dei Georgofili e di Via Palestro, delle quali oggi si conoscono raramente gli esecutori, mai i mandanti e spesso neanche il movente, susseguitesi mentre nel nostro Sud, grazie alla latitanza delle altre istituzioni dello Stato, uno dopo l’altro venivano uccisi tutti i Magistrati e i rappresentanti delle forze dell’ordine che della lotta alla mafia avevano fatto la propria ragione di vita, in una tragica sequenza che non ha eguali in nessuno degli altri paesi del mondo cosiddetto civile. Io mi chiedo invece, con amarezza , di quante altre stragi, di quanti altri morti avremo ancora bisogno perché da parte dello Stato ci sia finalmente quella reazione decisa e soprattutto duratura, come finora non è mai stata, che porti alla sconfitta delle criminalità mafiosa e soprattutto dei poteri, sempre meno occulti, ad essa legati, perché venga finalmente rotto quel patto scellerato di non belligeranza che, come disse il giudice Di Lello il 20 Luglio del 1992, pezzi dello Stato hanno da decenni stretto con la mafia e che ha permesso e continua a permettere non solo la passata decennale latitanza di boss famosi come Riina e Provenzano ma la latitanza e l’impunità di decine di “capi mandamento” che sono i veri padroni sia di Palermo che delle altre città della Sicilia. Da parte mia sono certo che non riuscirò a conoscere la verità in quel poco che mi resta da vivere dato che, a 65 anni, sono solo un sopravvissuto in una famiglia in cui mio padre, il fratello di mio padre, mio fratello, sono tutti morti a 52 anni, i primi per cause naturali, l’ultimo perché era diventato un corpo estraneo allo Stato le cui Istituzioni egli invece profondamente rispettava (sempre le Istituzioni, non sempre invece quelli che le rappresentavano). Spero soltanto che, in questo anniversario, mi siano risparmiate la vista e le parole dei tanti ipocriti che oggi piangono su Paolo e Giovanni quando, se fossero ancora in vita, li osteggerebbero accusandoli, nella migiore della ipotesi , di essere dei “professionisti dell’antimafia” o li farebbero addirittura spiare da squallidi personaggi come Pio Pompa come “nemici” o come “braccio armato della magistratura” . Chiedo solo, in questa occasione, di avere delle risposte ad almeno alcune delle tante domande, dei tanti dubbi che non mi lasciano pace. Chiedo al Proc. Pietro Giammanco, allontanato da Palermo dopo l’assassinio di Paolo, ma promosso ad un incarico più alto piuttosto che rimosso come avrebbe meritato, perché non abbia disposto la bonifica e la zona di rimozione per Via D’Amelio. Eppure nella stessa via, al n.68 era stato da poco scoperto un covo dei Madonia e, a parte il pericolo oggettivo per l’incolumità di Paolo Borsellino, le segnalazioni di pericolo reale che pervenivano i quei giorni erano tali da da far confidare da Paolo a Pippo Tricoli lo stesso 19 Luglio: “è arrivato in città il carico di tritolo per me”. A meno che, come affermato dal Sen. Mancino in un suo intervento del 20 Luglio alla camera, anche lui credesse che “Borsellino non era un frequentatore abituale della casa della madre” : infatti vi si recava appena almeno tre volte alla settimana! La stessa domanda inoltro all’allora prefetto di Palermo Mario Jovine anche se la risposta ritiene di averla già data con l’affermazione fatta in quei giorni: “Nessuno segnalò la pericolosità di Via D’Amelio” . Affermazione palesemente risibile : in quei giorni si erano susseguite le segnalazioni di possibili attentati a Paolo Borsellino e bastava interrogare gli stessi agenti della scorta, cinque dei quali morti insieme a lui, per sapere quali erano i punti più a rischio. Chiedo alla Procura di Caltanissetta, e in particolare al gip Giovanbattista Tona, il motivo dell’archiviazione delle indagini relative alla pista del Castello Utveggio: eppure proprio da questo luogo partirono, subito dopo l’attentato, delle telefonate dal cellulare clonato di Borsellino a quello del dott.Contrada, oggi finalmente condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per collusione e favoreggiamento. Chiedo alla stessa Procura di Caltanissetta, e sempre allo stesso gip Giovanbattista Tona, i motivi dell’archiviazione dell’inchiesta relativa ai mandanti occulti delle stragi. Per un’altra archivazione, quella relativa alle vicissitudini del fascicolo Fincantieri ho già inoltrato richiesta di chiarimenti in via ufficiale. Chiedo alla Procura di Caltanissetta di non archiviare, se non lo ha già fatto, le indagini relative alla sparizione dell’agenda rossa di Paolo e di chiarire il coinvolgimento dei tutte le persone, dei servizi e non, in essa coinvolte. Chiedo soprattutto al sen. Nicola Mancino, del quale ricordo, negli anni immediatamente successivi al 1992, una sua lacrima spremuta a forza durante una commemorazione di Paolo a Palermo, lacrima che mi fece indignare al punto da alzarmi ed abbandonare la sala, di sforzare la memoria per raccontarci di che cosa si parlò nell’incontro con Paolo nei giorni immediatamente precedenti alla sua morte. O spiegarci perché, dopo avere telefonato a Paolo per incontrarlo mentre stava interrogando Gaspare Mutolo, a sole 48 ore dalla strage, gli fece invece incontrare il capo della Poliza dott. Parisi e il dott. Contrada, incontro dal quale Paolo uscì sconvolto tanto, come raccontò lo stesso Mutolo, da tenere in mano due sigarette accese contemporaneamente. Altrimenti, grazie alla sparizione dell’agenda rossa di Paolo, non saremo mai in grado di saperlo. E in quel colloquio si trova sicuramente la chiave dalla sua morte e della strage di Via D’Amelio.
Salvatore Borsellino
Milano, 15 Luglio 2007
“Il Vangelo secondo Gesù Cristo” di Josè Saramago
8 luglio 2007 alle 16:45 | Pubblicato su Cultura | 1 commentoEro in dubbio se presentarvi prima “Saggio sulla Lucidità” che vede protagonisti gli stessi personaggi di “Cecità” oppure questo capolavoro di Saramago, a detta di molti il miglior libro del premio Nobel portoghese. Forse è meglio concedersi una pausa tra “Cecità” e “Saggio sulla lucidità” e buttarsi a capofitto sul “Vangelo secondo Gesù Cristo” (titolo originale, per gli esteti, “O Evangelho segundo Jesus Cristo). Un libro molto sofferto, una corrosiva rilettura della vita e del pensiero di Gesù; il libro che più di tutti ha scatenato le critiche della Chiesa portoghese e del Vaticano. Questo di Saramago è un “Vangelo” terribilmente umano, che permette al lettore di sentirsi spiritualmente vicino alla figura di Cristo, di un Gesù riportato a dimensioni umane e non divine, di un “poveruomo” come tanti altri “poveruomini” di questo mondo, peccatori e non.Prima neonato come tutti gli altri, poi in perenne lotta tra questo mondo, quello degli uomini e delle donne, dell’amore e del dolore terreno, e il mondo soprannaturale, quello del Padre, che non riesce a capire, i cui fini e confini, sono a lui come a tutti gli altri uomini, ignoti e imperscrutabili. Fino alla morte non desiderata e non voluta, lui stesso ignara vittima sacrificata ad una divinità indifferente, ingannato. Anche stavolta un Saramago che mi lascia a bocca aperta per la sua bravura.
Nella foto: La copertima del libro pubblicato in Italia da Einaudi. A destra J. Saramago
Un capolavoro della letteratura del novecento
12 Maggio 2007 alle 09:52 | Pubblicato su Cultura | Lascia un commentoVorrei proporre ai lettori del mio blog un libro “datato” che io considero un classico della letteratura italiana del dopoguerra. Come potete vedere dalla foto si tratta de «Le parrocchie di Regalpetra» di Leonardo Sciascia, il primo libro scritto nel lontano 1956 dal grande poeta e scrittore siciliano scomparso nel 1989. L’autore sintetizzò con queste parole il contenuto della sua “opera prima”: «Con queste pagine non metto una bandiera rossa al pianterreno: non saprei goderne l’effetto dalla terrazza; ne, restando al pianterreno, potrei salutarla con fede. Credo nella ragione umana e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono; ma pare che in Italia basta ci si affacci a parlare il linguaggio della ragione per essere accusati di mettere la bandiera rossa alla finestra.
Il Libro:
È una serie di cronache su un immaginario paese siciliano, nel quale sono ravvisabili le condizioni di qualsiasi altro paese dell’isola. In Sciascia c’è una risentita dimensione civile, una speranza nei poteri della ragione e nelle conquiste liberatrici della Storia, ma nel contempo una dolente coscienza delle carenze e delle colpe delle classi dirigenti di ieri e di oggi e del prezzo di dolore e di miseria che esse comportano.
L’opera di Sciascia assume sin dall’inizio il valore di testimonianza:in questo caso, denuncia del fascismo e denuncia sociale (condizioni del Meridione).
Lo stile è molto semplice. In questa prima opera c’è una marcata tendenza al neorealismo: il linguaggio è aderente al mondo rappresentato. Sciascia evita, tuttavia, di cadere nel folclore. Egli va più a fondo, alla sostanza dei problemi della Sicilia.
Biografia: Leonardo Sciascia, naque a Racalmuto, Agrigento nel 1921, scrittore noto per i suoi romanzi incentrati sul potere e la corruzione in Sicilia. Fu insegnante di scuola elementare a Caltanissetta dal 1949 al 1957 e a Palermo dal 1957 al 1968, pubblicando frattanto romanzi, racconti, opere teatrali e saggi che, come egli stesso affermò, formavano un’unica opera, mirante a illustrare la tragedia del passato e del presente della sua isola d’origine.Le parrocchie di Regalpetra (1956) è una raccolta di racconti che esaminano le condizioni della Sicilia rurale, sottoposta ai condizionamenti della mafia, del Partito fascista e, dopo la guerra, alla deviata gestione del potere da parte dei nuovi amministratori locali democristiani. Fecero seguito i racconti di Gli zii di Sicilia (1958) e i romanzi sulla Sicilia contemporanea, quali Il giorno della civetta (1961), A ciascuno il suo (1966) e Todo modo (1974), adattato cinematograficamente nel 1976 dal regista Elio Petri), incentrati sul racconto di indagini condotte dalla polizia: in essi però la suspence, tipica di questo genere narrativo, tende a proiettarsi in una dimensione filosofica e metaforica. Sempre caratterizzata da un intreccio da romanzo giallo è La scomparsa di Majorana (1975), sulla misteriosa sparizione del fisico catanese Ettore Majorana. Dal romanzo Il contesto (1971), anch’esso appartenente a questo gruppo di opere, derivò il film di Francesco Rosi Cadaveri eccellenti (1976). Anche Il consiglio d’Egitto (1963), Candido (1979) e altri romanzi mettono in scena, da diversi punti di vista e presentando vari ambiti sociali, aspetti della storia siciliana che, come già avveniva nelle opere di Pirandello, tende a trasformarsi in modello della condizione umana.Dal 1978 Sciascia si concentrò sull’attività saggistica e politica (L’affaire Moro, 1978; Dalla parte degli infedeli, 1979) e, come rappresentante del Partito radicale, divenne membro del Parlamento europeo e del Parlamento italiano nel 1979. Degli ultimi anni sono i romanzi brevi La strega e il capitano (1986), Porte aperte (1988, dal quale nel 1990 Gianni Amelio ha tratto l’omonimo film interpretato da Gian Maria Volonté) e Una storia semplice (1989), opere nelle quali dietro alla consueta avvincente traccia narrativa compaiono sempre più insistentemente contenuti di sofferta e profonda riflessione morale e filosofica.Sciascia morì a Palermo nel 1989.
Un libro per voi. « CECITA’» di Josè Saramago
21 aprile 2007 alle 16:47 | Pubblicato su Cultura | 6 commentiPubblicato in Italia nel 1996, è un romanzo allegorico sulla incapacità dell’uomo moderno di saper vedere e capire ciò che è e ciò che sta diventando. Improvvisamente un uomo diventa cieco, proprio mentre sta fissando un simbolo della stasi, dell’immobilità: un semaforo rosso. Ma non si tratta della cecità solita, descritta dalla letteratura medica, bensì di una cecità bianca, abbagliante. Come trovarsi immersi in un mare di latte. Presto si scopre che questo insolito e incredibile evento è contagioso. Senza possibilità di capire come, a poco a poco tutti gli abitanti dello Stato (quale non importa, il narratore non ce lo dice, nel suo resoconto) sono colpiti da questa disgrazia. All’inizio le persone vengono rinchiuse in un ex manicomio. Ed è in questo microambiente che conosciamo i protagonisti, nelle loro virtù e nelle loro miserie. Miserie a cui nessuno pensava di poter arrivare, ma la situazione fa saltare ogni norma sociale precedentemente rispettata. Una sorta di Signore delle Mosche, ma più crudo e teso. Tutto è impastato di escrementi, di sopravvivenza, di fame e di morte gratuita: specchio di quello che miliardi di persone nel mondo vivono tutti i giorni.
Non compare un nome proprio. I personaggi sono senza nome. E senza vista. Ma anche in questa “parabola” c’è qualcuno che non soggiace alle regole dei molti. È la moglie dell’oculista che ha visitato il primo uomo colpito dal “mal bianco”. Sorta di Messia, la moglie, che vede ciò che gli altri non possono vedere perché ciechi. L’ottusità morale ha bisogno di qualcuno o qualcosa che ci dica che stiamo per inciampare. Ma il prezzo da pagare è alto, se si è gli unici a vedere gli orrori che nessun altro può vedere. I ciechi possono commettere atrocità o semplici scorrettezze senza averne veramente rimorso. Il fatto di non avere un’immagine impressa nella mente del gesto compiuto rende il gesto, per quanto orribile, una specie di proiezione mentale. Una fantasia. Un sogno.
Poi salta tutto. C’è il caos totale. Anche i militari che sorvegliavano il manicomio diventano ciechi e i reclusi sono “liberi”. La società si riorganizza secondo i bisogni e i nuovi impedimenti. Si gira in piccoli branchi. Si cerca senza sosta il cibo vagando per la città. Si dorme ogni notte in posti diversi. Solo i “nostri” sono in grado di ritrovare la via per le proprie case, avendo una guida… Chi, a occhi chiusi, perso in una grande città, sarebbe in grado di riconoscere la propria strada, il proprio portone? In questo modo salta l’idea di proprietà. Chi tardi arriva… alloggia da un’altra parte, che tanto è uguale. E pensandoci noi gran parte delle nostre scelte le facciamo con gli occhi, non col cuore o secondo regole pratiche (una poltrona è meglio bella che comoda…).
È un resoconto, come si diceva, ma più che resoconto è un trattato (“ensaio”, dal portoghese, infatti può essere tradotto così, o anche: saggio). La cosa che salta più all’occhio è l’aspetto della pagina. Pagine monolitiche, con pochissimi paragrafi e a capo. La seconda cosa, leggendo, di cui ci si rende conto, è che la punteggiatura è utilizzata ai minimi termini: punti e virgole, e basta. Tutto di fila… E la cosa ha un senso, quando si arriverà a incontrare, verso la fine del romanzo, l’alter ego di Saramago. Uno scrittore cieco. E come scrive uno scrittore cieco che non conosce il braille?
Per vedere basta togliersi le bende che non ci accorgiamo di avere sugli occhi.
Il mio piccolo tributo all’Immenso Josè
2 aprile 2007 alle 19:26 | Pubblicato su Cultura | 1 commentoSolo cinque parole per definirlo: il più grande di tutti!
E credetemi non è assolutamente un giudizio di parte. Josè Saramago è il più grande scrittore poeta vivente. Primo portoghese a vincere il premio Nobel nel 1998, nonché autore di romanzi epici, che rimarranno nella storia della letteratura.
Considerato il massimo esponente della drammaturgia contemporanea, ha avuto non solo riconoscimenti da colleghi del mondo latino americano e da quello di lingua portoghese ( tra questi Jorge Amado, Montalban), ma anche da autorevoli critici letterari anglosassoni, tra questi il critico statunitense Harold Bloom, che nel suo libro “Il genio” ha definito Saramago “il romanziere maggiormente dotato di talento ancora in vita”.
Inoltre, riferendosi a lui come “Il maestro”, ha dichiarato: “è uno degli ultimi titani di un genere letterario in via di estinzione”.
Per quelli che non lo conoscono, qui di seguito una breve biografia , seguita da alcuni documenti trovati su vari siti che ci aiuteranno a conoscere meglio, oltre il Saramago, scrittore, poeta e drammaturgo, anche il Saramago uomo del nostro tempo.
Biografia:
José Saramago è nato ad Azinhaga, in Portogallo il 16 novembre 1922. Il suo primo romanzo, Terra del peccato, del 1947, non riceve un grande successo nel Portogallo oscurantista di Salazar.
Nel 1959 si iscrive al Partito Comunista Portoghese che opera nella clandestinità sfuggendo sempre alle insidie ed alle trappole della famigerata Pide, la poliziapolitica del regime. Negli anni sessanta Saramago diventa uno dei critici più seguiti del Paese nella nuova edizione della rivista “Seara Nova” e nel ’66 pubblica la sua prima raccolta di poesie I poemi possibili.
Diventa quindi direttore letterario e di produzione per dodici anni di una casa editrice e dal 1972 al ’73 curatore del supplemento culturale ed editoriale del quotidiano Diario de Lisboa.
Sino allo scoppio della Rivoluzione dei Garofani, nel ’74, Saramago vive un periodo di formazione e pubblica poesie (Probabilmente allegria, 1970), cronache (Di questo e d’altro mondo, 1971; Il bagaglio del viaggiatore, 1973; Le opinioni che DL ebbe, 1974) testi teatrali, novelle e romanzi.
Il secondo Saramago (vice direttore del quotidiano Diario de Noticias nel ’75 e quindi scrittore a tempo pieno), libera la narrativa portoghese dai complessi precedenti e dà l’avvio ad una generazione post-rivoluzionaria.
Lo scrittore pubblica il lungo romanzo Manuale di pittura e calligrafia nel ’77 e quindi nell’ottanta Una terra chiamata Alentejo sulla rivolta della popolazione della regione più ad Est del Portogallo. Ma è con Memoriale del convento (1982) che ottiene finalmente il successo tanto atteso.
In sei anni pubblica tre opere di grande impatto (oltre al Memoriale, L’anno della morte di Riccardo Reis e La zattera di pietra) ottenendo numerosi riconoscimenti. Gli anni Novanta lo consacrano sulla scena internazionale con L’assedio di Lisbona e Il Vangelo secondo Gesù, e quindi con Cecità. Ma il Saramago autodidatta e comunista senza voce nella terra del salazarismo non si è mai fatto avvincere dalle lusinghe della notorietà conservando una schiettezza che spesso può tradursi in distacco. Meno riuscito è il Saramago saggista, editorialista e viaggiatore, probabilmente frutto della necessità di tenere comunque la scena e di campare. Il suo Portogallo, sia nello scenario del passato che in quello contemporaneo sembra rifarsi alla concretezza della vita e ai suoi risvolti fantasiosi inglobati in una grande storia di cui lo scrittore si fa specchio.
Una delle sue grandi Opere:
Saggio sulla lucidità
“L’arte e la parte insieme mi autorizzano ad affermare che votare scheda bianca è una manifestazione di cecità altrettanto distruttiva dell’altra, O di lucidità, disse il ministro della giustizia, Che cosa, domandò il ministro dell’interno, ritenendo di aver udito male, Ho detto che votare scheda bianca si potrebbe considerare come una manifestazione di lucidità da parte di chi l’ha fatto, Come osa, in pieno consiglio del governo, pronunciare una simile barbarità antidemocratica, dovrebbe vergognarsi, non sembra neanche un ministro della giustizia, sbottò quello della difesa.”
Persa tra le virgole, gli incisi, le lunghissime frasi, l’impaginazione fitta e regolare senza paragrafi, non riesco a rialzare lo sguardo, continuo a leggere e non voglio fermarmi. La storia, avvincente come un noir, assorbe e trascina con sé, lucidamente. Non condivido l’opinione espressa da Bruno Arpaia sul Domenicale del Sole 24 Ore di opera “al di sotto delle attese”. Personalmente giudico Saggio sulla lucidità superiore ad alcuni tra gli ultimi romanzi di Saramago, sicuramente all’altezza di Cecità, cui tra l’altro si riferisce, o de La caverna, per citare due opere a mio giudizio insuperabili. La difficoltà, come sempre, sta nel parlarne. Questo è un libro che necessita di un periodo di riflessione prima di poterlo presentare. Del resto recensire un romanzo di Saramago è impresa pretenziosa e forse inutile. Tanto varrebbe scrivere “leggetelo” e chiudere lì. Superfluo dire quanto sia intensa e profonda la sua scrittura, originale la forma narrativa, intellettualmente altissima la vicenda narrata: lo saprete già avendo letto qualsiasi altro libro del Premio Nobel portoghese. Dovrei presentare una pagina bianca, rifacendomi proprio al cuore di questa storia, entrando anch’io nel novero di quei “biancosi” che sconvolgono il sistema politico di una nazione. Così infatti vengono definiti, disprezzandoli, i cittadini della capitale di un imprecisata nazione democratica, che in larghissima parte scelgono di depositare una scheda bianca nell’urna di una tormentata tornata elettorale. È il primo di una serie di atti concatenati che scoprono il vero volto di una democrazia di facciata, che legge qualsiasi anomalia nel comportamento dei cittadini come una temibile destabilizzazione del sistema e che perciò è disposta a commettere qualsiasi atto, anche violento, per riportare alla “vera” democrazia chi si è permesso di minarla dall’interno votando (lecitamente, del resto) scheda bianca. Chi dirige questa rivolta collettiva? Perché nulla sembra efficace a fermarla? Inutili la condanna pubblicamente espressa dai massimi dirigenti nazionali, l’isolamento anche istituzionale in cui si sceglie di lasciare la capitale, l’infiltrazione nella rete sociale di spie, l’attentato governativo attribuito ai “biancosi” con molte vittime, le minacce di totale abbandono degli abitanti a sé stessi. Saramago lucidamente porta il lettore nelle pieghe del potere, nei suoi meccanismi, e parallelamente, pur senza spiegarci in modo esplicito né la genesi di questa ‘rivolta’ del tutto pacifica né le sue motivazioni fondamentali, ci fa comprendere come una popolazione scoraggiata e disillusa possa arrivare con un invisibile e inudibile passaparola a questa scelta estrema, ma legale. Fino a ricollegare la vicenda con la protagonista di Cecità, capro espiatorio necessario volendo spiegare in un rapporto di parentela “la cecità generale di quattro anni addietro e questa, maggioritaria, di ora”.
Molti romanzi di Saramago potrebbero essere definiti “politici” (e in qualche modo questa sua visione della realtà è stata in gran parte la motivazione del premio Nobel), ma Saggio sulla lucidità lo è in misura ancora maggiore. Un’analisi impietosa, dura, caustica e pessimista del sistema delle democrazie occidentali, una denuncia critica e tristemente ironica delle armi che la democrazia usa per difendere sé stessa, una teorizzazione della possibile autonomia ‘anarchica’ di una città che non porta affatto allo sfacelo.
Non dimentichiamo infine la traduttrice, Rita Desti, artefice di un lavoro straordinario e difficilissimo: rendere in lingua italiana la qualità e il livello della scrittura di Saramago.
Le interviste 1
Quali sono i suoi legami con un pensiero religioso che necessariamente la figura di San Francesco esprime?
J.S.- Prima di tutto quest’opera teatrale non tratta della seconda vita di san Francesco d’Assisi, ma si chiama “La seconda vita di Francesco d’Assisi”, e ciò dimostra che sono interessato più alla vita dell’uomo in quanto tale che non alla sua santità.
È vero che può sembrare contraddittorio che una persona come me, le cui opinioni politiche, ideologiche e filosofiche sono tanto lontane dalla trascendenza – che sia questa di matrice cristiana o altro – si possa interessare come scrittore e uomo a questi temi, ma io non lo ritengo tale.
La religione e la trascendenza sono temi con i quali hanno a che fare tutte le persone, non sono riservati solo ad alcuni, e dunque io come scrittore, occupandomi della vita delle persone, mi occupo a mia volta di questi temi che hanno a che fare con la dimensione del trascendente.
D’altra parte, per quanto i miei rapporti con la religione siano, come dire, di osservatore non credente, non posso negare di avere una mentalità cristiana, non certo animista, né islamista, né buddista, né quella di nessun’altra religione.
Mentalmente io sono un cristiano, la mia è una mentalità cristiana, e dunque a questo titolo credo di potermi e dovermi occupare,come scrittore, di temi che apparentemente non dovrebbero riguardarmi ma che, dal punto di vista in cui di volta in volta mi pongo, sono tanto miei quanto di Giovanni Paolo II. I.-
Mi sembra che questo accento che lei pone sulla umanità di San Francesco, metta la religione in una luce diversa, non tanto forse come espressione di fede, ma di impegno nel mondo e nella vita. È questo ciò che lei coglie nella figura di Francesco?
J.S.- Sicuramente i tempi sono cambiati e questo è innegabile, però allo stesso tempo e sicuramente in questo caso, esistono delle continuità.
La chiesa di oggi, che non ha alcuna similitudine con la chiesa dei tempi della sua fondazione né tanto meno con quella dei tempi di San Francesco, usa le parole e l’immagine di questo personaggio come elemento legittimante della propria attuale posizione, e questo è un aspetto che, tra presente e passato, può servire a capire meglio il presente.
La storia, la visione del passato offrono un’interpretazione della storia di oggi. Credo che questo sia uno dei temi fondamentali della sua scrittura. Cecità è forse un libro scritto in una dimensione presente, ma sembra essere un presente senza tempo, mentre quasi sempre i suoi libri usano un tempo passato, anche se quasi come una chiave di interpretazione per leggere il presente.
Come si pone di fronte all’idea della Storia e della forma del romanzo storico?
J.S.- C’è un equivoco sull’idea del romanzo storico, su cosa sia, e in che modo si occupi di un presente o invece di un passato più o meno lontano da noi. Marguerite Yourcenar, scrivendo le sue Memorie di Adriano, non ha certo scritto un romanzo storico, ma un romanzo che in qualche modo parla del presente. C’è un modo di scrivere che sta al di là della contingenza. Per esempio nel caso di Kafka, il quale non parla di Praga, non parla della città e della gente che ci vive, come ad esempio fa invece Pessoa, ma parla di un tempo che è un tempo assoluto e come tale anche nostro, che gli consente di uscire dal contingente, dall’immediato e di andare all’essenziale. Questo è ciò che secondo me rende grande la letteratura di Kafka.
Faccio presente che stiamo parlando di Kafka e non di José Saramago!
Proprio la scrittura, il senso della parola, sono così importanti nella sua letteratura. In alcuni casi, come per esempio all’inizio de L’assedio di Lisbona, è bastato aggiungere una parola, la negazione no, per cambiare il senso di una storia. Nel caso di Francesco, lei diceva prima che la Chiesa usa ancora la sua parola per legittimarsi oggi. Ma la parola di Francesco, così semplice ed essenziale, riesce ancora ad essere densa, pregnante, piena di significato nel mondo di oggi, che è un mondo così diverso dal mondo di allora, come lei stesso diceva?
J.S. – Quando Francesco ritorna questa seconda volta alla vita, trova una situazione drammatica, una Chiesa e una compagnia molto diverse da quelle che lui aveva lasciato, e inizialmente vorrebbe tornare alla purezza delle origini, ma i tempi sono cambiati ed è costretto a prendere coscienza dell’impossibilità di tornare indietro.
Ma ciò che, come autore, mi interessa di più, è come in questa rinascita, in questo ritrovare così cambiato ciò che aveva lasciato, possa essere messo in luce un equivoco – che forse nel Tredicesimo secolo poteva non essere letto come tale, ma che oggi non può non essere visto in questa chiave – ed è l’equivoco della povertà.
Se la povertà di Francesco agli inizi poteva essere una povertà santa, evangelica e come tale piena di valore e di significato, quello che lui stesso avrà modo di scoprire, nel conflitto che nella sua seconda vita nascerà con i suoi antichi compagni, è che non si può più sostenere in alcun modo che essa sia santa, come afferma ancora ipocritamente la Chiesa.
È dunque qui, in questo punto che si gioca il senso della storia, di questa rilettura della parola stessa di Francesco. I poveri esistono e non sono santi, né aspirano ad esserlo.
Ecco, mi sembra che qui ritorni quella parola che in un’intervista lei disse essere così importante, perché è la parola “no”, che permette di rifiutare ciò che non si considera giusto e non si vuole. In questo caso è no alla povertà, all’accettazione di un mondo il cui ordine sia stabilito. No resta una parola importante per lei…
J.S.- “No” alla povertà, “no” all’ingiustizia, “no” alla crudeltà. È curioso notare che l’unico essere crudele sulla terra è l’essere umano…gli animali non sono crudeli. Non lo è la tigre né il leone, che hanno bisogno di uccidere per nutrirsi.
L’unico animale veramente crudele che esiste è l’uomo: che uccide per piacere, per passione, per vendetta, per odio, per tutte le ragioni che più o meno sappiamo; e che oltre a uccidere, tortura. Nessun animale tortura un altro animale, ed è a questo che bisogna dire no.
Lei parla di violenza e di povertà, e sono due argomenti molto presenti in tanti territori d’oltremare che sono stati anche territori portoghesi, come l’Africa, parte dell’Asia ma forse meno, e il Sud America con la grande estensione del Brasile. Il Portogallo ha “esportato” una letteratura, una cultura e un sapere. Che cosa ha ricevuto in cambio la cultura portoghese da questi mondi così diversi, non fosse altro che per il colore ma anche per il modo di pensare delle persone che li abitano? C’è stato uno scambio, è possibile che questa attenzione alla povertà non abbia a che vedere con questa altra dimensione, parallela, del Portogallo che sta al di là del mare?
J.S.- Non so, credo di no, penso che di tutti i paesi che hanno ricevuto la lingua, la cultura o il dominio portoghese, l’unico che abbia poi trasformato in tutti i suoi aspetti questo lascito culturale in modo autonomo e compiuto sia il Brasile, la cui lingua nazionale è il portoghese, il quale in realtà è parlato da una minoranza dei tanti abitanti di questo immenso stato e spesso deformato, ma il Portogallo non è il proprietario esclusivo di questa lingua, e in Brasile ci sono comunque duecento milioni di abitanti.
Il Brasile ha sviluppato questo lascito, questa lingua, questa cultura e, nonostante non sia un paese economicamente forte, già negli anni Cinquanta e Sessanta la letteratura brasiliana ha influenzato il Portogallo. Questo ora però non avviene più molto. A parte il Brasile, i problemi degli altri paesi di cui si parla, la loro povertà, le loro tensioni, la situazione di crisi permanente in cui vivono non ha mai dato loro la possibilità di sviluppare compiutamente una cultura sufficiente a consentire uno scambio paritario.
Dialoghi fra culture in realtà ce ne sono molti e, come è ovvio, non soltanto tra paesi che parlano il portoghese. Il Portogallo ha un vicino molto prossimo che è la Spagna, con una lingua diversa che io credo lei parli e conosca benissimo. L’impressione che si ha da un po’ più lontano, come dall’Italia, è che essi siano vicini e si assomiglino ma che siano anche molto diversi. Secondo lei quali sono gli elementi di differenza e di somiglianza dei due paesi? Lei in un romanzo ha immaginato che la penisola iberica si staccava dal resto dell’Europa e si portava dietro anche gli spagnoli, quindi qualcosa di simile ci deve essere…
J.S.- Probabilmente questo ha a che vedere con le mie personali relazioni culturali e geografiche con la penisola iberica. Io ho sempre detto che mi sento prima di tutto portoghese, poi iberico, e poi, a volte, anche europeo.
Vivo nelle isole Canarie, mia moglie è spagnola e perciò ho infinite relazioni con la Spagna, anche se questo non mi allontana idealmente dal Portogallo, perché nella mia testa ora è molto più consistente questa idea fisica, questa unità geografica della penisola iberica. Quanto a somiglianze e differenze fra Portogallo e Spagna, sono accaduti degli eventi che hanno segnato profondamente il tipo di relazioni esistenti ancora oggi tra i due paesi.
Uno di questi è stato quando per sessanta anni, per volontà del re di Castiglia, i regni di Spagna e di Portogallo furono riuniti e il Portogallo fu proclamato sotto il dominio spagnolo, e questo è stato un duro colpo per l’orgoglio e l’indipendenza portoghesi.
A partire dal Sedicesimo secolo, poi, l’importanza del Portogallo nell’ambito europeo è sistematicamente diminuita. Inoltre, il nostro paese era ed è all’estremo dell’Europa, dalla quale siamo separati dai Pirenei, e tutto ciò che è accaduto di negativo nella nostra storia è arrivato attraverso la Spagna, anche se poi erano per esempio invasori francesi, e quindi il nostro atteggiamento nei suoi confronti è di una certa paura, come a dire: “da quel lato arriva solo male”.
Al di là della Spagna c’è un’Europa molto lontana per un paese sospeso ai suoi estremi, con altra cultura vicina oltre a quella dell’infinito del mare che lo fronteggia. Esperienze comuni e distinte si confrontano in queste due culture, che hanno sviluppato un simmetrico processo di distanza.
Come i portoghesi vivono la Spagna con una forma di timore, come la porta di influenze negative, così gli spagnoli hanno sviluppato un forte complesso di amputazione: in effetti, se si guarda la carta geografica della Spagna priva del Portogallo, appare una forma assai strana, e un po’ come colui che ha perso un arto e sente ancora dolore, così gli spagnoli percepiscono il Portogallo e distolgono lo sguardo da esso, facendo finta che non esista, pensando di eliminare così il dolore dell’amputazione.
C’è un reciproco aspetto delle due culture nel quale tendono a dimenticarsi per annullare le negatività reciproche.
Eppure, sebbene quest’Europa sia lontana, inizia o finisce sulla soglia dei Pirenei, lei ha dei legami culturali forti con questo continente. In una sua intervista recentemente pubblicata in Italia, lei indica tra i suoi riferimenti più importanti Gogol, Montaigne, Kafka, e poi Cervantes che è iberico e padre Antonio Vieira che è invece un portoghese; ma la Russia, la Cecoslovacchia di Kafka e la Francia illuminista ci sembrano esprimere legami molto forti che lei ha con il resto del continente.
J.S.- È chiaro che, come dicevo, il fatto di essere prima portoghese, poi iberico e quindi europeo ha più a che vedere con la realtà storica attuale, quella che chiamano costituzione dell’Europa, e con le culture europee delle quali mi sono nutrito, che con la storia dell’Europa e le sue linee culturali passate.
D’altra parte la scelta dei personaggi che costituiscono la mia ideale famiglia di riferimenti (Gogol, Kafka, Montaigne, Cervantes) non è espressione della scelta di un’intera cultura ma di un singolo, e del mio interesse personale verso particolari persone e il loro modo di essere uomini, artisti e di stare al mondo.
La Russia non è solo Gogol, la Spagna non è tutta Cervantes, né la Francia è completamente Montaigne. Sono delle lezioni, dei fili da seguire che si scelgono. Lo stesso padre Antonio Vieira, gesuita del XVII secolo, è da considerarsi forse uno dei più grandi scrittori della lingua portoghese parlata e scritta, anche se non ha scritto né poesie né romanzi.
Venne a Roma, fu missionario e diplomatico, pregò nella chiesa di Sant’Antonio dei portoghesi, ma soprattutto denunciò con grande lucidità il genocidio perpetrato dal Portogallo ai danni degli indios brasiliani, come faceva Bartolomeo De las Casas nei domini spagnoli, dimostrando così già allora l’esistenza di una sensibilità moderna che potesse accorgersi dei genocidi operati nel nuovo mondo. Quindi non si tratta di scegliere pezzi di Europa, ma persone, con percorsi, posizioni e sguardi politici particolari.
Vorrei lanciare anche uno sguardo politico attraverso di lei sul Portogallo che, visto dall’Europa che comincia aldilà dei Pirenei, sembra un paese in grado più di altri di resistere a una forma di modernità forte e dilagante. Penso ad esempio al suo romanzo Cecità, che pone quasi una barriera rispetto a una certa cultura del visivo, capace di divorare il mondo e di consumarlo. A cosa crede sia dovuta questa capacità del Portogallo di rimanere più fedele a sé, non fuori dal tempo, ma critico rispetto a certi aspetti del presente?
J.S. Non so, mi piacerebbe pensare che sia così come lei lo descrive, ma in realtà il Portogallo, come tutti gli altri paesi, negli ultimi dieci venti anni è molto cambiato, fa parte di questo processo culturale che tende ad uniformare le differenze, ciò che viene definito di solito politicamente corretto o globalizzato.
D’altra parte il Portogallo è un paese piccolo, sono dieci milioni di abitanti e tre, quattro milioni di emigranti sparsi per il mondo. Questo può dare una maggior lucidità, chiaroveggenza rispetto all’evolversi dei problemi, ma non può certo dare la forza per sottrarvisi. Inoltre Cecità l’ha scritto un portoghese, ma avrebbe potuto essere scritto da un tedesco, un italiano, un francese, uno spagnolo, un inglese, da chiunque abbia coscienza del mondo in cui si vive e dei problemi che il presente ci sottopone.
Mi sembra molto importante quello che lei dice di Cecità, sembra un libro epico, che ha una sua indipendenza, con uno sguardo universale, diverso, distinto, parallelo al resto della sua produzione. È così, o è solo un’impressione da lettore?
J.S.- Credo che sia così. Cecità non è un libro solo, ma è un libro inaugurale, che segna una nuova fase del mio lavoro; dopo il Vangelo secondo Gesù (1991), e insieme a Tutti i nomi e a La caverna, che sto scrivendo ora, costituisce una trilogia sul tempo di oggi, uno sguardo sulle trasformazioni dell’uomo nel presente, e il mio ultimo saluto, come scrittore, al ventesimo secolo. Vorrei precisare che questi tre libri non sono stati pensati come un insieme, ma riguardando ciò che ho scritto e detto, mi sembra di cogliere in essi una certa unità. E se mi permettete un ulteriore eccesso di presunzione, mi piace pensare che, se oggi Kafka fosse vivo e potesse scrivere, forse scriverebbe Cecità.
José Saramago. Dalla lettura per il Premio Nobel, 7 dicembre 1998
«L’uomo piú saggio che io abbia conosciuto non sapeva né leggere né scrivere. Alle quattro di mattina, quando la promessa di un nuovo giorno stava ancora in terra di Francia, si alzava dal pagliericcio e usciva nei campi, portando al pascolo la mezza dozzina di scrofe della cui fertilità si nutrivano lui e sua moglie, i miei nonni materni. […] Talvolta, nelle calde notti d’estate, dopo cena, mio nonno mi diceva: “José, stanotte dormiamo tutti e due sotto il fico” […]. In piena pace notturna, tra gli alti rami dell’albero, mi appariva una stella, e poi, lentamente, si nascondeva dietro una foglia, e, guardando da un’altra parte, come un fiume che scorre in silenzio nel cielo concavo, sorgeva il chiarore opalescente della Via Lattea. E mentre il sonno tardava ad arrivare, la notte si popolava delle storie e dei casi che mio nonno raccontava: leggende, apparizioni, spaventi, episodi singolari, morti antiche, zuffe di bastoni e pietre, parole di antenati, un instancabile brusio di memorie che mi teneva sveglio e al contempo mi cullava. Non ho mai potuto sapere se lui taceva quando si accorgeva che mi ero addormentato, o se continuava a parlare per non lasciare a metà la risposta alla domanda che gli facevo nelle pause piú lunghe che lui volontariamente metteva nel racconto: “E poi ?”
[…] Molti anni piú tardi, scrivendo per la prima volta di mio nonno Jeronimo e di mia nonna Josefa, mi accorsi che stavo trasformando le persone comuni che erano state in personaggi letterari, e che questo era probabilmente il modo per non dimenticarli, disegnando e ridisegnando i loro volti con un lapis cangiante di ricordi […]. Nel dipingere i miei genitori e i miei nonni con i colori della letteratura, trasformandoli da semplici persone in carne e ossa in personaggi di nuovo e in modi diversi costruttori della mia vita, senza accorgermene stavo tracciando il percorso attraverso il quale i personaggi che avrei inventato, gli altri, quelli veramente letterari, avrebbero fabbricato e mi avrebbero portato i materiali e gli arnesi che, finalmente, nel buono e nel meno buono, nel sufficiente e nell’insufficiente, nel guadagnato e nel perduto, in quello che è difetto, ma anche in quello che è eccesso, avrebbero finito per fare di me la persona in cui oggi ancora mi riconosco: creatore di quei personaggi, ma al tempo stesso loro creatura».
Le parole sono l’unica cosa immortale; quando uno è morto, ai posteri rimangono solo loro.
José Saramago fissa in una frase il perché del proprio scrivere. Probabilmente ora il futuro ricordarà di lui anche l’appartenenza alla lista d’oro dell’Accademia di Svezia. Ma lui non vede il premio in chiave di fama universale:”Una grande responsabilità, ecco cos’è. Sono il primo portoghese a vincerlo e ne sento l’importanza. Ora la mia linguaraggiungerà più persone, più lettori. La letteratura del mio Paese, non solo per i miei libri, potrà occupare uno spazio più considerevole nella coscianza culturale dei popoli. Non smetterò mai di dire che una cultura della periferia non è cultura periferic”.
Assediato da centinaia di giornalisti e di fotografi, nel recinto della Fiera del Libro di Francoforte, ve da una dichiarazione all’altra senza dimenticare i suoi punti fermi: il comunismo, il non europeismo, l’amore per la Lusitania di mare e di viaggi che trova sintesi nella vecchia Lisbona, terra delle radici e, insieme, luogo mitico, simbolo, riferimento costante.
“Io cosa sono se non uno scrittore Portoghese? Scrivo in portoghese, penso in portoghese, sento in portoghese. Le traduzioni non mi hanno trasformato in cosmopolita.”. Ha quindi ringraziato “tutti i traduttori, validi interpreti del mio pensiero” e così sintetizzato la sua poetica: L’importante è non credere all’apparenza delle cose. Chi è da tutte le parti non è da nessuna parte.”
Poi, una coda semipolemica: a chi gli chiede come spenderà i denari del premio, ha risposto: “Non giocando al Casino, né comprando macchine di lusso o televisioni. Siamo così abituati al fatto che gli scrittori debbano essere poveri che ogni volta che uno scrittore dispone di più soldi del normale gli chiedono cosa intenda farne. Ma perché queste domande non le fate mai a tennisti e calciatori?”.
Torna poi a parlare del suo antieuropeismo. “L’unione Europea, ho detto spesso, terrà in pochissimo conto i rapporti di potere fra i diversi Paesi che la compongono. Ci saranno Paesi forti e Paesi deboli che dovranno obbedire. In Europa si sta consolidando un potere che riduce i cittadini a consumatori. In una cornice mondiale che, tra l’indifferenza generale, sta distruggendo sistematicamente volontà, ideologie, coscienze”.
Tutto ciò nel contesto della bandiera rossa che ha sempre avvolto la poetica di José: “Resterò fino alla fine dei miei giorni un comunista, ma non mi parlate di stalinismo: l’ho sempre condannato”.
Le interviste 2
José Saramago è il primo portoghese a vincere il premio Nobel per la letteratura: anzi, il primo portoghese a vincere un premio Nobel. E l’ha vinto, nel 1998, perchè “con parabole sostenute da immaginazione, compassione e ironia ci mette continuamente in grado di apprendere un’elusiva realtà”. Una di quelle parabole, un religioso “Vangelo secondo Gesù” scritto da un ateo, fece stracciare nel 1992 le vesti ai farisei portoghesi e spinse lo scrittore in un esilio volontario alle Canarie, dove da allora vive.
In questi giorni invece Saramago è in Italia, invitato dal sindaco di Roma, e in concomitanza di questa visita Einaudi pubblica la prima traduzione mondiale del suo ultimo romanzo, “L’uomo duplicato”. Per l’occasione abbiamo ripercorso con lui le tappe salienti dell’impressionante produzione letteraria di un autore straordinario non soltanto per la sua ispirazione e il suo stile, ma anche per la sua formazione.
“Lei non ha studiato lettere, ma meccanica. Anzitutto, come mai?”
Se “studiare lettere” significa frequentarne la facoltà, allora bisogna dire che non l’ho studiata, visto che non ho fatto l’università. Ma bisogna anche dire che non ho studiato “meccanica”, nel senso profondo della parola, perchè l’Istituto Tecnico (secondario, non superiore) in cui mi formai aveva un programma molto diversificato, con materie quali portoghese, francese, letteratura, matematica, fisica, chimica, scienze naturali, disegno tecnico, laboratorio (di tornitoria meccanica) … Per difficoltà economiche non proseguii con gli studi di ingegneria. Il mio primo lavoro fu, dunque, di tornitore meccanico: operaio, cioè.
“Che influsso hanno avuto questi studi sulla sua produzione letteraria? Penso, ad esempio, alle descrizioni della costruzione dell’edificio e della macchina volante nel “Memoriale del convento”.”
Più che i miei studi, che come ho detto non meritavano di essere chiamati “scientifici”, ho usato documenti dell’epoca. Naturalmente, però, senza l’immaginazione dello scrittore questa documentazione sarebbe rimasta più o meno lettera morta.
“Come mai ha scelto una professoressa di matematica per il ruolo della suicida in “Tutti i nomi”?”
Non c’era nessuna ragione speciale. Affinchè il signor José potesse penetrare clandestinamente nella scuola, la donna sconosciuta doveva essere una professoressa. Ma invece di matematica, poteva essere di qualunque altra materia. E non pensi che a scuola io avessi la minima inclinazione, teorica o pratica, per l’aritmetica: in realtà, non sono mai stato bravo a contare …
“E come mai è un professore di matematica a suggerire al protagonista del suo ultimo romanzo, “L’uomo duplicato”, di vedere il film dal quale si origina il conflitto narrato nella storia?”
Ancora una volta si tratta, probabilmente, di una casualità. A meno che si voglia vederci un’eco di “Tutti i nomi”, o una simmetria.
“Crede che sia solo un caso che, in un mondo tecnologico e scientifico, molti grandi scrittori o abbiano fatto studi scientifici (da Musil a Gadda), o abbiano mostrato un grande interesse per questioni scientifiche (da Borges a Calvino)?”
Non ho un’opinione al riguardo. Credo comunque che la formazione umanista di un numero molto maggiore di scrittori, non li abbia inibiti. Quanto a me, sono nato in una famiglia di contadini, analfabeti o quasi, non ho posseduto libri fino a diciannove anni, non ho fatto altri studi che un corso tecnico elementare: e nonostante questi e altri svantaggi, che pesano su quell’autodidatta che sono, sono diventato uno scrittore.
“A proposito di Borges, che ruolo svolge il libro di Herbert Quain “The god of the labirinth” in “L’anno della morte di Ricardo Reis”? Sta forse a suggerire un’analogia tra il rapporto Borges-Quain, e quello Pessoa-Reis?”
Non vedo questa analogia. Reis è uno degli “alter ego” di Pessoa, si può dire carne della sua carne e spirito del suo spirito, mentre Quain è solo uno dei prodotti della biblioteca immaginaria di Borges. Le opere degli eteronimi di Pessoa “dialogano” tra loro, e costituiscono la sua opera ortonima. Tra le opere che Borges ha scritto, e quelle che ha attribuito a Herbert Quain, non c’è invece nessun tipo di dialogo.
“La citazione di “The God of the Labyrinth” non sarà comunque casuale, no?”
E’ semplicemente un libro inesistente che Reis, per caso, prende nella biblioteca della nave che lo trasporta da Rio de Janeiro a Lisbona. In qualche modo, “L’anno della morte di Ricardo Reis” è tutto un “luogo” di inesistenze: non esiste “The God of the Labyrinth”, non esiste Ricardo Reis, e neppure Fernando Pessoa esiste più, al momento della narrazione.
“In “Storia dell’assedio di Lisbona” lei dice: “Il mistero della scrittura è che in essa non c’è alcun mistero”. Cosa significa questa affermazione?”
Le ricordo questi versi di Alberto Caeiro: “L’unico senso intimo delle cose, è che non hanno nessun senso intimo”. E ancora: “Il mistero delle cose? Che cosa è mai il mistero! L’unico mistero è che ci sia qualcuno che pensa al mistero”. Nella medicina antica si diceva di un farmaco che aveva, ad esempio, “una virtù purgativa”. Non si conoscevano, o si conoscevano male, le cause dell’effetto che produceva, ma la parola “virtù” serviva a millantare una conoscenza. Coi “misteri” è la stessa cosa. Credo che il fatto che durino, o perdurino, derivi quasi sempre dal pregiudizio di andare a cercare ciò che sta dietro alle parole: quasi sempre, infatti, non c’è nulla.
“E perchè quell’affermazione si trova all’interno di un libro i cui tre livelli (quello di Saramago, quello dello storico e quello del revisore) si intrecciano invece molto misteriosamente?”
Sembra che i livelli del libro non siano soltanto tre. Qualche anno fa, un professore dell’Università di Siviglia, Adrián Huici, isolò “otto testi” principali che, secondo lui, si moltiplicano all’infinito con un effetto di “mise an abyme”. Probabilmente ho scritto che “il mistero della scrittura è che non ha nessun mistero” per proteggere la mia salute mentale …
“Si riconoscerebbe, almeno per quanto riguarda la sua produzione a partire da “Cecità”, in quella che Calvino chiamava “letteratura deduttiva”? In una letteratura, cioè, che parte da un’idea iniziale che funge da assioma, e la sviluppa come nella dimostrazione di un teorema?”
Mi ci riconosco, al punto che allargherei questa definizione di Calvino in modo da coprire, praticamente, tutto l’insieme della mia opera. Tanto per citare solo tre esempi: “L’anno della morte di Ricardo Reis” (Reis vive, Pessoa esce dalla tomba per incontrarsi col suo eteronimo), “La zattera di pietra” (la penisola iberica si stacca dall’Europa), e “Storia dell’assedio di Lisbona” (il revisore nega la vera storia, che i crociati hanno aiutato i portoghesi nella conquista di Lisbona dai mori).
“Quali sono i suoi rapporti personali con la pittura, che svolge un ruolo importante nel “Manuale di calligrafia e pittura”, e con la musica, alla quale lei dedica le pagine su Scarlatti nel “Memoriale del convento”?”
Sono i semplici rapporti di un estimatore ragionevolmente informato e sensibile. La triste realtà è che disegno come un bambino, e che non suono nessuno strumento.
“E quali sono i suoi rapporti personali con la religione, da ateo che ha però scritto un poetico “Vangelo secondo Gesù”? Un libro, cioè, che i clericali considerano blasfemo, e gli anticlericali apologetico?”
La contraddizione non sta a me risolverla. Ma se Matteo (II, 16) non si fosse preoccupato di raccontare l’episodio della strage degli innocenti, il mio “Vangelo” non esisterebbe: fu la duplice assurdità di questa carneficina, storica o leggendaria che sia, che mi spinse a scrivere il libro.
“In che senso il martirio degli innocenti è una “duplice assurdità”?”
Anzitutto perchè è assurdo chiamare “martiri” di una religione dei poveri bambini che di essa non sapevano nulla, per la semplice ragione che il fondatore di questa religione iniziò la sua predicazione trent’anni dopo. In secondo luogo, è ancora più assurdo, ammesso che l’assurdità abbia gradazioni, supporre che il bambin Gesù avrebbe potuto essere ucciso nella strage di Erode, per la semplice ragione che Dio non avrebbe mai inviato il proprio Figlio sulla terra per farlo sgozzare a pochi mesi. Benchè la stupidità sia uno degli attributi divini, non credo che Iahvé (era lui, no?) sarebbe caduto tanto in basso.
“Qual è il suo pensiero sulla globalizzazione, alla quale è in un certo senso dedicata “La caverna”?”
Se si facesse la globalizzazione del pane, starei dalla parte dei globalizzatori. Ma non fino a quando ci sarà una persona al mondo condannata a morir di fame.
“Da ultimo, che difficoltà incontra a mantenere il suo impegno comunista, che ha in parte ispirato “Una terra chiamata Alentejo”, dopo la caduta del muro di Berlino e l’instaurazione del “nuovo ordine” americano?”
Nessuna difficoltà. Il comunismo, per me, è di natura ormonale. Oltre all’ipofisi, io ho nel cervello una ghiandola che secerne ragioni affinchè io sia stato e continui a essere comunista. Quelle ragioni le ho trovate, un giorno, condensate in un motto de “La Sacra Famiglia” di Marx e Engels: “Se l’uomo è formato dalle circostanze, bisogna formare le circostanze umanamente”. Le circostanze non le ha formate umanamente il socialismo pervertito, e tanto meno le formerà mai il capitalismo, che è pervertito per definizione. Dunque, il mio cervello continua a secernere ormoni …
Il « Saramago pensiero»:
- Il mistero della scrittura è che in essa non c’è alcun mistero.
- Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni.
- Nessuno può essere senza essere, uomo e donna non esistono, esiste solo ciò che sono e la ribellione contro ciò che sono.
- La fine del ventesimo secolo ha visto scomparire il colonialismo, mentre si ricomponeva un nuovo impero coloniale. Nel territorio degli Stati Uniti non c’è nessuna base militare straniera, mentre ci sono basi militari statunitensi in tutto il mondo.
- È un difetto comune di dire più facilmente quello che credono che gli altri vogliano sentire, piuttosto che attenersi alla verità. Tuttavia, purché gli uomini possano attenersi alla verità, dovranno prima conoscere gli errori e poi commetterli.
- Non è la dimensione del vaso che importa, ma quello che ognuno di noi riesce a mettervi, anche se dovrà traboccare e andare perduto.
- La vittoria della vanità non è la modestia, tanto meno l’umiltà, è piuttosto il suo eccesso.
- Tutto nel mondo sta dando risposte, quel che tarda è il tempo delle domande.
- Tutto il sapere è in Dio. Ma il sapere di Dio è come un fiume d’acqua che corre verso il mare, è Dio la fonte, gli uomini l’oceano, non valeva la pena di aver creato tanto universo se non dovesse essere così.
- Oltre alla conversazione delle donne, sono i sogni che trattengono il mondo nella sua orbita.
- Penso che per gli studenti sarebbe molto meglio partire dalla contemporaneità. Si rimane sempre indietro di un secolo; nella scuola si vive come dentro una specie di capsula senza collegamento con il tempo presente, mancano i nessi.
- Tutte le cose, le animate e le inanimate, stanno sussurrando misteriose rivelazioni, ma ciascuna dicendo la sua, e tutte discordanti, perciò non riusciamo a capire e patiamo quest’angoscia di essere sul punto di conoscerle e di non conoscerle.
- Siamo in guerra ed è una guerra di accerchiamento, ognuno di noi assedia l’altro ed è assediato, vogliamo abbattere le mura dell’altro e mantenere le nostre. L’amore verrà quando non ci saranno più barriere, l’amore è la fine dell’assedio.
- Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, la pietra che ha cambiato posto.
- Il soldato è come chi dalla morte non vede altro modo di allontanarsi, sapendo comunque che se la ritroverà davanti una e tante volte e non volendo credere che la vita debba essere nient’altro che una serie transitoria di rinvii.
- Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.
- È vero che le cicale cantano, ma è un canto che viene da un altro mondo, è lo stridore dell’invisibile sega che sta tagliando le fondamenta di questo.
- E se il cuore non ha capito, non arriva ad esser menzogna il detto della bocca, ma piuttosto assenza.
- Per me il titolo contiene tutta quanta l’idea del libro. Per questo ho sempre trovato i titoli prima di cominciare a scrivere. Anche se questo non significa che abbia già un piano compiuto del romanzo.
- Ci sono cose che un uncino fa meglio di una mano intera, un uncino non sente dolore se deve fissare un filo e un ferro, non si taglia, né si brucia, e io ti dico che Dio è monco, e ha fatto l’universo.
- Il viaggio non finisce mai, solo i viaggiatori finiscono.
- Dovrebbe bastar questo, dire di uno come si chiama e aspettare il resto della vita per sapere chi è, se mai lo sapremo, poiché essere non significa essere stato, essere stato non significa sarà.
- Quanto alla leggerezza del fardello, così dovrebbe essere ogni volta che uomo e donna portano con sé ciò che hanno, e che ciascuno di loro si porti dentro l’altro, per non dover ritornare sui loro passi, è sempre tempo perduto e basta.
- Si dice che il male non regge a lungo, anche se, per la fatica che si porta dietro, a volte sembra di si, ma quello su cui non c’è dubbio è che il bene non dura per sempre.
- I viaggiatori possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: “Non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero.
- Il mondo sarebbe assai migliore se ciascuno si accontentasse di quello che dice, senza aspettarsi che gli rispondano, e soprattutto senza chiederlo né desiderarlo.
- Forse solo il silenzio esiste davvero.
- Il tempo, a volte, sembra che non passi, è come una rondine che fa il nido sulla grondaia, esce ed entra, va e viene, ma sempre sotto i nostri occhi.
- Hanno riposato qui e là per la strada, silenziosi, né avevano di che dire, se perfino una sola parola è di troppo quando è la vita che sta cambiando, molto di più che se siamo noi che cambiamo in essa.
- Sapere dove è l’identità è una domanda senza risposta.
La gioventù non sa quel che può, la maturità non può quel che sa.
Blog su WordPress.com.
Entries e commenti feeds.